
Coronavirus
Bergamo, 12 febbraio 2021 - Un altro 11 settembre. Questo è stato il Covid in Bergamasca. Non uno tsunami, ché di tsunami ce ne sono stati diversi - sottolineano i sanitari che si sono trovati in prima linea - ma un evento epocale, di svolta. Da quel 20 febbraio 2020 nulla è stato più uguale in Lombardia prima e nel mondo poi. Per rendersene conto basta chiedere a bruciapelo: "Lei dov'era quel giorno?". Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e area critica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, senza esitazioni risponde: "A Roma, relatore a un convegno assieme a un collega di Codogno. Quel pomeriggio mi fece vedere il messaggio che aveva ricevuto sul telefonino, abbiamo concluso il nostro intervento, declinato la cena con i colleghi e siamo rientrati col primo treno. L'indomani ero in ospedale per partecipare all'unità di crisi".
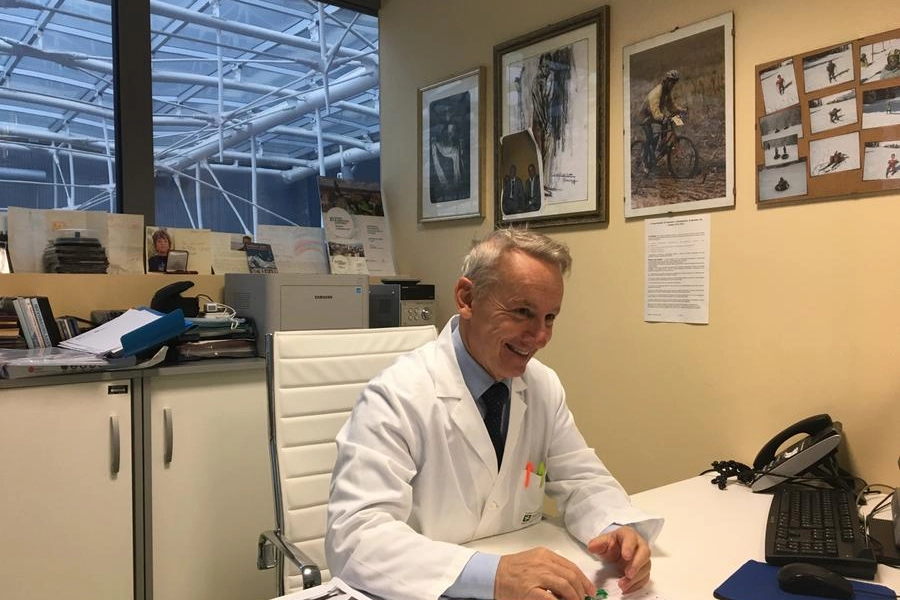
Lorini non ha preso il Covid, ma è come se il virus gli fosse rimasto attaccato sulla pelle, come una cicatrice, di quelle che non si cancellano. "A febbraio e marzo, dopo le mie solite 12-13 ore in reparto, tornavo a casa la sera ascoltando musica e pensando a cosa avrei fatto l'indomani se fossero arrivati altri pazienti Covid, dove li avremmo messi, come avremmo potuto curarli". La risposta del territorio in quei giorni è stata eccezionale: le donazioni si sono susseguite e anche i gesti di generosità di imprenditori e gente comune. "Alcuni amici, ex campioni di enduro, - racconta commosso Lorini - hanno messo all'asta i loro inseparabili cimeli per acquistare le attrezzature che servivano. In quei giorni ho conosciuto una solidarietà mai vista, tutto il mondo unito contro un nemico comune: non era mai successo prima nella storia dell'umanità. Ecco, su questa solidarietà, credo, si dovrebbe costruire il futuro".
L'abbiamo vinta questa battaglia? "Siamo ancora dentro la partita - risponde fermo Lorini - , ma questa partita finisce bene perché ho visto una cosa importantissima: tutti, dai medici al personale delle pulizie, hanno fatto la loro parte senza risparmiarsi. E la scienza ha fatto miracoli. Qui a Bergamo abbiamo fatto i monoclonali la seconda settimana di marzo e mi viene da ridere quando sento che il governo li ha approvati ora. La scienza ha ottenuto un vaccino nella metà del tempo necessario". A proposito del vaccino, lei è stato il primo a farlo a Bergamo. "Si, volevo dare un segnale. Ho fatto le due dosi e ho tutti gli anticorpi. Mi auguro che tutti lo facciano, è un dovere morale e civico perché non si ripeta più ciò che è successo". Cosa pensa di no vax e negazionisti? "Gli direi: liberi di non vaccinarsi ma se il Covid non esiste, allora siate coerenti e non venite in ospedale se prendete il virus". E' stato detto più volte, e da più voci, che nei giorni caldi dell'emergenza i posti letto venivano dati a chi aveva maggiori aspettative di vita, per età e gravità della malattia, è vero? "Ho firmato tante circolari in quei giorni, ma nessuna con indicazioni del genere".
Cosa le rimane di questo anno? "Ancora credo di non esserne del tutto fuori. Devo realizzare, metabolizzare quello che ho vissuto in quei mesi in cui sembrava che non ci fosse via d'uscita. Mi restano due immagini che non dimenticherò: una mamma che assieme alle sue due bimbe, giorni fa, mi ha consegnato un ricamo di Bergamo con la scritta "Rinascerò", spiegandomi di averne fatto un pezzo al giorno per stare idealmente vicina a chi lottava in corsia. L'altra immagine è il sorriso di un collega che per sei mesi è stato ricoverato, tra la vita e la morte, nel mio reparto. Ora viene a trovarmi per la riabilitazione e il suo sorriso, per me, vale più di un Nobel".
Circa 400 operatori del Papa Giovanni hanno contratto il virus nella prima ondata Covid. Molti fanno ancora i conti con gli strascichi a livello fisico ed emotivo. "Diversi medici e infermieri sono seguiti tuttora da psicologi per aiutarli a superare lo stress emotivo - spiega Fabio Pezzoli, 63 anni, dal 2016 direttore sanitario del Papa Giovanni XXIII -. Non erano abituati a vedere così tanta gente morire, e in quel modo. Io stesso tornavo a casa la sera e non dormivo pensando a ciò che avrei visto l'indomani". Al Papa Giovanni, 900 posti letto, di cui 73 di terapia intensiva, uno dei più grandi d'Italia, il tasso mortalità si aggira sui 100 casi all'anno, nella prima ondata Covid morivano 25 persone al giorno. "Siamo stati l’unico ospedale al mondo, dopo Wuhan, a fronteggiare un numero di contagi impensabile - ricorda Pezzoli -, avevamo 120 persone al giorno in pronto soccorso, tutte positive e molte da ricoverare in terapia intensiva. Non sapevamo più dove mettere i malati. Abbiamo dovuto riorganizzare l'ospedale in pochi giorni, senza indicazioni sul virus, ancora quasi sconosciuto. Abbiamo stilato i primi protocolli e su quelli ha lavorato il resto del mondo, ma noi navigavamo a vista".

Anche Pezzoli è stato contagiato nella prima ondata. "Il 9 marzo mi sono svegliato con la febbre - racconta - ho capito che era Coronavirus, l'aveva preso anche il direttore generale. Non nascondo che ho avuto paura quando la saturazione dell'ossigeno è scesa a 88. Sono rimasto chiuso in casa per 15 giorni, passavo 12 ore al giorno al telefono per gestire la situazione in ospedale".
Lei ha fondato il Tribunale per i diritti del malato a Bergamo, ritiene che qualcosa di più poteva essere fatto per salvare più vite? Abbiamo fatto il possibile e l'inimmaginabile in quella situazione e con le poche conoscenze che avevamo del virus. Dove hanno sbagliato ad Alzano? O meglio, lei avrebbe riaperto l'ospedale? "E' troppo facile parlare col senno di poi. Posso solo dire che nessuno, e sottolineo nessuno, all'inizio ha capito la portata di ciò che stava accadendo". Cosa non riesce a dimenticare di quei giorni? "Gli occhi di quel centinaio di persone in pronto soccorso che ti guardano e cercano una risposta e tu non puoi dargliela, perché non ce l'hai una risposta. E poi la fatica di comunicare ai familiari la perdita dei loro cari. So cosa significa il distacco senza nemmeno il conforto di un addio perché mia suocera è morta di Covid il 22 marzo in Rsa, sola. Abbiamo avuto le sue ceneri un mese dopo. In Bergamasca quasi non c'è famiglia che non abbia fatto i conti con questo dolore".
UN ANNO DI COVID: IL NOSTRO SPECIALE

